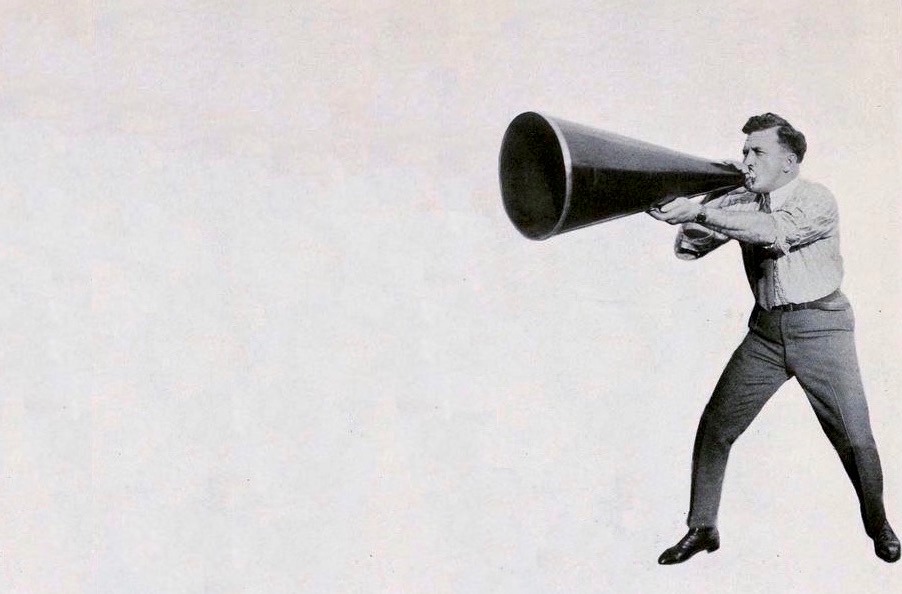Secondo lei
collaborazione artistica Paola Rota
Secondo lei
Lisistrata
SPETTACOLO ACCESSIBILE
Lisistrata
Lo zoo di vetro
traduzione Gerardo Guerrieri
con Mariangela D’Abbraccio, Gabriele Anagni
Lo zoo di vetro
Perfect Days
regia Enoch Marrella
lo spettacolo fa parte di MaturAzione III
Perfect Days
Giovani promesse. Concerto sinfonico
violino Vikram Francesco Sedona
con Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
direzione d’orchestra Massimo Raccanelli
Giovani promesse. Concerto sinfonico
News
-
Fortunato Ortombina, nuovo sovrintendente della Scala di Milano. Le congratulazioni della Fondazione Teatro Stabile del Veneto
"A nome di tutta la comunità del Teatro Stabile del Veneto mi congratulo con il Maestro Fortunato Ortombina per la meritatissima designazione a sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. Negli anni trascorsi alla Fenice ha saputo portare il teatro veneziano ai vertici tra le eccellenze artistiche in Italia e nel mondo. Questa nomina rappresenta un riconoscimento che onora l’intero movimento...
Leggi tutto -
Scomparsa Paola Gassmann, il cordoglio del Teatro Stabile del Veneto
“Con la scomparsa di Paola Gassman la famiglia del Teatro Stabile del Veneto perde insieme una cara amica e un’attrice di grande talento, che più e più volte ha contribuito a far splendere i nostri palcoscenici. Fin dai primi anni ’80 assieme a Ugo Pagliai, suo compagno di vita oltre che di teatro, ha emozionato il pubblico del Teatro Goldoni, debuttando poi in almeno dieci produzioni e...
Leggi tutto -
Quando la moda si fa arte: il progetto #backtoart per la ri-generazione della bellezza
McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet riafferma il suo impegno verso l'economia circolare, l'arte e la sostenibilità con un nuovo progetto: la mostra installativa Come un manto per le lucciole dell’artista Olimpia Biasi.
Presentata a Venezia, nel foyer del Teatro Goldoni, l’opera, commissionata da McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet grazie alla collaborazione con la Fondazione...
Leggi tutto -
Avviso variazione orari di apertura biglietterie
Caro pubblico,
da aprile gli orari di apertura delle biglietterie dei nostri teatro subiranno delle variazioni come segue:
Teatro Verdi di Padova
-da martedì a sabato: ore 10.30 - 13.00 e 15.00 - 18.30-domenica e lunedì: chiuso (in caso di spettacolo la biglietteria apre 1 ora prima dello spettacolo)
Chiusure per festività: sabato 30 marzo, giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio
Teatro...
Leggi tutto -
Avviso sostituzione spettacolo Venere Nemica al Teatro Verdi
Care spettatrici e cari spettatori,
Vi comunichiamo che, per motivi di salute dell’artista, lo spettacolo Venere Nemica con Drusilla Foer in programma al Teatro Verdi di Padova dal 17 al 21 aprile sarà sostituito dallo spettacolo Secondo Lei di e con Caterina Guzzanti.Gli abbonamenti e i biglietti precedentemente acquistati per lo spettacolo Venere Nemica restano validi per il nuovo titolo.Gli...
Leggi tutto